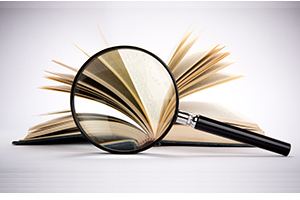La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport – ha diramato, in data 09/07 u.s., la bozza della legge di riforma dello sport, redatta ai sensi della Legge delega 8 agosto 2019 n. 86. Si tratta di una prima bozza, che sarà molto probabilmente oggetto di numerosi interventi correttivi, dalla quale emerge tuttavia la “vision” del provvedimento che, peraltro, era già stata esplicitata nell’art. 1 della Legge Delega. Nel presente articolo, dopo avere operato una rapidissima sintesi, cercheremo di individuare i passaggi di maggiore interesse, dal punto di vista civilistico, tributario e giuslavoristico, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rinviando a successivi articoli di approfondimento l’analisi più approfondita degli stessi, nonché degli ulteriori, importanti interventi di natura più “politica” e strutturale che impattano in misura rilevante sulla struttura dello sport nazionale, che, fatte salve improbabili retromarce, ne risulterà rivoluzionato.
La tempistica
La legge delega aveva previsto un termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa (31/08/2019) per l’emanazione di uno o piùdecreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore.
Il termine ordinario per l’emanazione del provvedimento scadrebbe dunque il 31/08/2020, termine che potrebbe slittare al 30/11/2020 a seguito alla proroga generalizzata di tre mesi disposta in considerazione dell’emergenza Covid-19 per l’adozione dei decreti legislativi con termine in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020. Il ministro Spadafora ha tuttavia ribadito in diverse occasioni la volontà di rispettare la scadenza originariamente prevista dalla legge delega.
La tempistica dell’entrata in vigore non è questione di poco conto, considerato l’impatto che molte disposizioni avranno sotto gli aspetti organizzativo ed economico dei sodalizi sportivi, tenuto conto che l’inizio della prossima stagione sportiva – salvo rinvii dettati da disposizioni di natura sanitaria – è alle porte, e che le società sportive stanno predisponendo, se già non l’hanno fatto, i necessari programmi operativi e ed i relativi budget.
Si ricorda, peraltro, che, ai sensi del comma 2 della Legge Delega, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
Se la volontà è quella di fare entrare in vigore la riforma entro il primo di settembre prossimo, i tempi per la presentazione dello schema di decreto alle commissioni parlamentari sono dunque strettissimi.
Il decreto – come indicato all’art. 5 della parte VI (disposizioni finali) dello stesso – “entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.”, fatti salvi alcuni articoli – fra i quali quelli che disciplinano la sicurezza dei lavoratori e la disciplina del lavoro sportivo che, per espressa previsione delle disposizioni finali, entreranno in vigore il 01/01/2022.
Dunque, se i tempi fossero rispettati, la riforma avrebbe immediato impatto sulla stagione sportiva in partenza, il che ci porta subito a operare una considerazione, che è poi anche un auspicio: considerata la delicatezza dei temi trattati, e l’impatto che le nuove norme avranno sulla “carne viva” dei sodalizi sportivi (oltre che della struttura dello sport nazionale) sarebbe forse opportuno prendersi un po’ più di tempo per vagliare al meglio diversi passaggi, e prevedere entrate in vigore differenziate tra le varie disposizioni, e dilazionate all’inizio della stagione sportiva 2020/2021 per alcune di esse.
Non vorremmo che, per la fretta, la gatta facesse i gattini ciechi.
La definizione di “attività sportiva”
Viene finalmente, per la prima volta, data una definizione di “sport”, intendendosi per tale
qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole codificate che, attraverso una partecipazione organizzata o non, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.
Si tratta di una definizione molto interessante, che avrà un impatto importante anche a livello tributario e giuslavoristico.
La prima domanda che sorge spontanea, a tal fine, è se e come tale definizione potrà coniugarsi con l’individuazione delle discipline sportive riconosciute (e non riconosciute) dal CONI ai sensi delle delibere 1566 e seguenti, anche ai fini dell’iscrizione al “Registro” ai sensi del regolamento di cui alla delibera 1574 del 18/07/2017.
Per fare un esempio ed entrare subito nel concreto: il Crossfit, che, come noto, non rientra tra le discipline sportive attualmente riconosciute dal CONI, potrà rientrare nel nuovo concetto di “attività sportiva”?
Se la risposta fosse affermativa (come ritiene chi scrive), lo svolgimento di tale attività dovrà essere circoscritto nell’ambito del Terzo Settore o potrà essere svolto anche a livello di società o associazione sportiva dilettantistica (con tutte le conseguenze del caso)?
Non solo: il riferimento al “miglioramento della condizione fisica e psichica” e allo “sviluppo delle condizioni sociali” quali modalità alternative (“o”) all’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli sdoganerà lo svolgimento dell’attività sportiva finalizzata al mero benessere fisico dalla necessità di svolgimento di manifestazioni sportive e dal rischio che in sede di verifica venga contestato lo svolgimento di “attività commerciale finalizzata al soddisfacimento di bisogni individuali”?
Il tutto, tenendo anche in considerazione le nuove funzioni e le nuove modalità di funzionamento del Registro delle ATTIVITA’ sportive dilettantistiche che andrà a sostituire l’attuale Registro delle SOCIETA’ e ASSOCIAZIONI sportive dilettantistiche (si veda infra)
Lo strumento del “Testo Unico dello Sport”.
La prima considerazione (positiva) è sullo strumento: l’art. 1, c. 1, della legge delega, aveva delegato il governo ad adottare …. uno o più decreti legislativi… per il riordino della normativa.
La strada scelta sembra essere quella del decreto unico, attraverso il quale viene predisposto un “Testo Unico per lo Sport”. Scelta che, a nostro avviso, va valutata positivamente: da tempo si perorava un riordino della complessa normativa civilistica, tributaria e giuslavoristica dell’attività sportiva, le cui disposizioni risultano sparse in numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo e poco coordinate tra loro.
La tecnica appare simile a quella utilizzata nella predisposizione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), anche per il rinvio a decreti attuativi che dovranno essere emanati successivamente per disciplinare specifici argomenti.
Premesso quanto sopra il risultato appare un po’ confusionario e rivedibile: le vari disposizioni sono suddivise in sei “parti” a loro volta sotto-suddivise in “capitoli” 1 con una tecnica di “copia/incolla” delle precedenti disposizioni che risulta poco coordinata e, in alcuni passaggi, non chiarissima (ad es. il capo III “Delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche” del Titolo II “DEGLI ENTI PRIVATI” risulta, sostanzialmente, analogo all’art. 90 della L. 289/2002, fatte salve alcune – importanti – integrazioni e variazioni).
Ancora: analogamente a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, sono previsti numerosi richiami ad altre disposizioni (codice civile, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.p.r. 633/1972 (IVA), L. 398/1991, Art. 25, L. 133/1999, D.lgs. 276/2003 – Legge Biagi-, D.lgs. 81/2015 – Job Acts – ed altri) che rimangono in vigore “ove compatibili”, ovvero, in alcuni passaggi, quali disposizioni di riferimento alle quali è il T.U. dello sport che andrà a derogare.
Il risultato finale è un deficit di chiarezza e intellegibilità che potrebbe ancora essere sanato: fatto lo sforzo, si potrebbe puntare a un testo più coordinato e che ambisca a essere norma primaria di riferimento per il settore sportivo, in deroga (ove possibile) agli strumenti ordinari.
Da ultimo: manca (soprattutto in relazione alla riforma del lavoro sportivo) una disposizione “liberatoria” per il passato, in assenza della quale il rischio che gli organi ispettivi, e la giurisprudenza, leggano le nuove previsioni legislative come una sostanziale presa d’atto e una definizione normativa dello status quo ante è elevato.
Trattandosi di una prima bozza c’è (ci dovrebbe essere) il tempo per apportare le necessarie correzioni e interventi migliorativi. Ci auguriamo che l’atteggiamento dei vari stakeholders sia in questo senso costruttivo e non ci si trovi di fronte – come accaduto in passato in relazione ad altri tentativi di riforma – a chiusure preconcette tese a difendere pedissequamente posizioni consolidate e/o imposizioni (dall’alto) ideologiche.
I rapporti e le analogie con il codice del Terzo Settore.
Il D. Lgs. 117/2017 viene richiamato in diverse occasioni dalla bozza di T.U., tanto che, tra i due settori, sembra emergere un trait d’union ben preciso:
– Lo sport potrà essere praticato, e gestito, anche a livello di Terzo Settore (e questa non è una novità, posto che l’attività sportiva dilettantistica è espressamente prevista tra le attività di interesse generale ex art. 4 del Codice del T.S.);
– Le a.s.d. potranno assumere anche la qualifica di ETS;
– Le s.s.d. potranno assumere anche la qualifica di Impresa Sociale (con possibilità di deliberare, entro certi limiti, distribuzioni di utili ai soci e rimborsare, al valore nominale, le quote di capitale sottoscritte dai soci);
– Debuttano, in ambito sportivo, i concetti di “attività principale” – ergo: attività sportiva – e di “attività secondarie e strumentali” – ergo: attività commerciali – (in analogia alle “attività di interesse generale” e alle “attività diverse” previste, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore). Le attività secondarie potranno essere svolte solamente entro certi limiti da definirsi con decreti dell’Autorità di governo.
– L’individuazione del concetto di “lucro indiretto” viene esplicitamente mutuata da quella prevista dalla disciplina delle imprese sociali;
– Viene istituita anche nella legislazione sportiva la figura del volontario (prestazioni sportive amatoriali) che, tuttavia, come vedremo, potrà percepire, a certe condizioni, premi e compensi occasionali, nonché rimborsi spese;
– Gli Enti di Promozione Sportiva fuoriescono dall’ambito CONI – pur potendo continuare ad affiliare società e associazioni sportive dilettantistiche – saranno riconosciuti dal Dipartimento per lo sport e si occuperanno di attività fisico-sportive dilettantistiche con finalità ricreative e formative. Di fatto, saranno proiettati nell’ambito del Terzo Settore.
La riforma della governance dello sport
Si tratta del tema sul quale, al momento, si sono concentrate le maggiori attenzioni (e le maggiori critiche) da parte degli organi di stampa, e sul quale staremo, volutamente, molto in superficie, sia perché il presente lavoro rappresenta una semplice presentazione di una bozza di T.U. che potrà subire (e, probabilmente, subirà) notevoli variazioni, sia, soprattutto, perché la mission di questa rivista è quella di analizzare gli aspetti tecnico-giuridici e di guidare i dirigenti sportivi nell’interpretazione delle norme.
Volendo semplificare e schematizzare gli effetti della riforma, i punti salienti appaiono i seguenti:
1. Vengono rafforzate le competenze statali in materia di sport, le quali sono attribuite all’Autorità di Governo delegata dal Presidente del C.d.M.;
2. Viene a tal fine istituito il Dipartimento per lo Sport quale struttura amministrativa della Presidenza del C.d.M. il quale, tra le altre funzioni:
- Esercita la vigilanza sul CONI e sulla società Sport e Salute S.p.A.;
- Vigila sull’utilizzo dei contributi da parte delle F.S.N.;
- Cura e coordina le procedure inerenti alla concessione di agevolazioni e contributi in materia di sport;
- Riconosce gli Enti di Promozione Sportiva, i quali non faranno più parte del Consiglio Nazionale del CONI, e vigila sugli stessi;
3. Vengono rivisti, attraverso una revisione del c.d. “decreto Melandri (D. Lgs. 242/1999) il ruolo, l’organizzazione e le funzioni del CONI, il quale:
- Assolve le missioni previste dalla carta olimpica e, quindi, si occuperà prevalentemente della preparazione degli atleti;
- Recepisce i principi mondiali Antidoping e collabora con la NADO Italia per l’adozione delle misure di prevenzione;
- Riconosce le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate (ma non più gli Enti di Promozione Sportiva) ed esercita sulle stesse poteri di vigilanza, con possibilità di disporne il commissariamento, ma solo in relazione a gravi violazioni degli statuti e dei regolamenti sportivi (e non più per questioni amministrative e contabili, che saranno di competenza dell’Autorità di governo);
- Gestisce l’albo degli agenti sportivi;
- Stabilisce i criteri per la distinzione dell’attività sportiva professionistica da quella dilettantistica;
- Delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento delle società e associazioni sportive;
4. Vengono posti limiti più stringenti al numero di mandati dei vertici del CONI (massimo due mandati, anziché tre) e delle FSN (massimo tre mandati, anziché 3+1);
5. Viene rivista la dotazione di personale e di beni strumentali tra il CONI e la società Sport e Salute S.p.A.;
6. A livello territoriale verrà istituito un comitato territoriale per la promozione dello sport, presieduto da un rappresentante della Regione e composto da membri indicati dall’amministrazione scolastica, dal CONI, dal Cip, da Sport e Salute e dagli enti di promozione sportiva. Il CONI – come previsto dalla legge delega – avrà un rappresentante territoriale (probabilmente coincidente con l’attuale presidente regionale) con funzioni di mera rappresentanza territoriale, che dovrà curare i rapporti con le articolazioni periferiche delle F.S.N.;
7. Vengono (ri)definiti gli stanziamenti annuali e i criteri di finanziamento di CONI, Sport e Salute e Federazioni Sportive Nazionali, prevedendo che l’Autorità di Governo competente in materia di Sport potrà stabilire che l’accesso alla contribuzione pubblica sia riservato solamente alle Federazioni Sportive “che abbiano un numero minimo di atleti tesserati e che il finanziamento statale non possa comunque superare un multiplo prefissato dell’autofinanziamento prodotto dai medesimi soggetti”, introducendo indici di rappresentatività ed efficienza sinora non esistenti;
8. Viene ribadita la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, le quali avranno piena autonomia politica, organizzativa, gestionale, amministrativa, tecnico-scientifica e contabile rispetto al CONI, pur essendo riconosciuto in capo alle stesse il regime giuridico di attività di interesse generale – ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter della L. 241/1990 – in relazione a una serie di attività, tra le quali l’affiliazione di società e associazioni sportive, e la procedura di tesseramento e il riconoscimento ai fini sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche. Come chiarito dal Ministro Spadafora nella diretta FB tenutasi il 13 luglio, le FSN non saranno più inserite nell’elenco ISTAT delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni pubbliche. Ciò comporterà una serie di semplificazioni a livello amministrativo.
9. Viene completamente stravolto il ruolo degli Enti di Promozione Sportiva: come sopra accennato, questi saranno riconosciuti dal Dipartimento dello Sport, non faranno più parte del Consiglio Nazionale del CONI, e saranno tenuti a presentare ogni anno al Dipartimento dello Sport il bilancio consuntivo e preventivo, nonché una relazione dettagliata in ordine all’utilizzazione dei contributi pubblici. Il Dipartimento per lo sport, in caso di gravi irregolarità, può disporre la revoca del riconoscimento sportivo.
10. Il fine istituzionale degli EPS dovrà essere la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive dilettantistiche con finalità ricreative e formative, a livello multidisciplinare, per tutte le fasce di età e categorie sociali, pur potendo stipulare apposite convenzioni con le FSN. In concreto, è sancita la separazione tra sport “olimpico/agonistico”, posto sotto l’egida del CONI, e sport “sociale”, svolto dagli EPS sotto le direttive del Dipartimento dello Sport, i cui legami con l’attività sportiva gestita a livello di Terzo Settore saranno inevitabilmente destinati a intensificarsi;
11. Viene stabilito che – fermo restando la competenza delle FSN nella definizione dei settori professionistici e dilettantistici – la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere: porte aperte, dunque, al professionismo femminile (il quale dovrà riuscire a trovare un equilibrio finanziario, ma questa è un’altra problematica);
12. Viene previsto (entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto) l’abolizione del vincolo sportivo nel settore dilettantistico (posto che in quello professionistico l’abolizione opera ormai da tempo) “secondo modalità e parametri stabiliti dalle FSN in relazione all’età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società o associazioni sportive”.
Sono poi previste specifiche disposizioni per disciplinare e regolamentare il comitato paralimpico italiano, le misure Antidoping, i gruppi sportivi militari, lo svolgimento di attività sportive con impiego di animali, la figura dell’agente sportivo, i diritti audiovisivi, le norme sulla sicurezza dell’impiantistica sportiva e sullo svolgimento degli sport invernali.
Come si vede, una rivisitazione, e in qualche passaggio una rivoluzione, poderosa del sistema giuridico sportivo attualmente in vigore, che sarà oggetto di una serie di approfondimenti su questa rivista in relazione alle singole materie oggetto di delega, non appena il decreto risulterà definitivamente approvato.
La nuova disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche
La disciplina delle a.s.d. e s.s.d. viene sostanzialmente mutuata dall’attuale disciplina dell’art. 90, L. 289/2002 (che, tuttavia, non viene abrogato), rispetto alla quale sono previste alcune, importanti, variazioni:
i. In relazione alla forma giuridica, viene previsto che le società sportive possano assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste al libro V del codice civile: quindi non solo società sportive di capitali e cooperative (come attualmente disciplinato) ma (in teoria) anche società di persone (SNC, SaS o, addirittura, Società Semplice). L’ipotesi appare più teorica che pratica, atteso che appare difficoltoso coniugare la disciplina di tali società con l’assenza del fine di lucro richiesto alle sportive dilettantistiche. Non solo, la bozza soffre di un difetto di coordinamento, laddove, all’articolo successivo, prevede che solo alle società di capitali e cooperative si applichino le disposizioni del codice civile. Si tratta in tutta evidenza di un refuso al quale potrà essere data soluzione in sede di revisione della bozza stessa.
ii. “I predetti enti, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.”
Si tratta, questo, di un passaggio estremamente importante: viene esplicitamente prevista la compatibilità del “mondo” sportivo dilettantistico con il codice del Terzo Settore, ivi compresa la natura di impresa sociale, il che comporta una serie di conseguenze a livello di rimborsabilità delle quote sociali e potenziali (limitata) distribuibilità degli utili sulle quali ci soffermeremo nel prosieguo.
La bozza di T.U. non ne fa cenno, ma appare inevitabile che i sodalizi sportivi che intendessero iscriversi anche nel Registro Unico del Terzo Settore dovranno rispettare i requisiti e predisporre gli adempimenti previsti da entrambe le normative. Quanto al trattamento tributario, del quale ci occuperemo nel prossimo paragrafo, il sodalizio sportivo che intendesse assumere anche la qualifica di ETS dovrà applicare il regime fiscale del Terzo Settore in forza dell’esplicita previsione dell’art. 79 del C.T.S.
Meno semplice appare l’individuazione della disciplina giuslavoristica applicabile al sodalizio che si iscriva in entrambi i registri, posto che la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro sportivo – sulla quale ci soffermeremo in apposito capitolo – risulta in certi passaggi difficilmente conciliabile con le previsioni del Codice del Terzo Settore.
iii. Quanto ai requisiti statutari, viene operato un richiamo quasi totale alle disposizioni del comma 18 dell’art. 90, L. 289/2002, con una precisazione importante in relazione all’oggetto sociale e all’assenza del fine di lucro:
- L’oggetto sociale dovrà prevedere “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica riferita all’avvio, all’aggiornamento e al perfezionamento nelle attività sportive”
I passaggi evidenziati in neretto rappresentano le variazioni rispetto all’attuale testo dell’art. 90, c. 18.
Il riferimento all’attività stabile e principale deve essere letto unitamente al successivo articolo 4 (attività secondarie e strumentali), ai sensi del quale Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiamo carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In sostanza, mutuando la disciplina degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore, l’attività principale e prevalente dei sodalizi sportivi dilettantistici dovrà essere, per l’appunto, lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (compresa la didattica), laddove lo svolgimento delle attività “diverse” (tipicamente le attività commerciali di sostegno all’attività istituzionale/decommercializzata) sarà consentito, ma solamente in via sussidiaria, ed entro limiti definiti con decreto governativo.
Di nuovo, riappare la logica che governa la disciplina del Terzo Settore, laddove il finanziamento delle attività solidaristiche e di utilità sociale è delegato alla capacità di reperire fondi sul “mercato” della solidarietà.
Questo passaggio è molto delicato, e dovrà essere gestito (a livello di decretazione governativa) con grande equilibrio: è infatti di tutta evidenza che – appurato che l’obiettivo della norma è evidentemente quello di evitare gli abusi rappresentati dallo svolgimento di attività commerciali dietro lo “schermo” associativo e sportivo dilettantistico al solo fine di sfruttare i benefici fiscali di settore – occorre evitare che l’effetto finale sia quello di impedire, o comunque rendere eccessivamente difficoltosa, l’attività di autofinanziamento dei sodalizi sportivi.
Lo svolgimento – operato in trasparenza e nel pieno rispetto delle disposizioni amministrative, tributarie e giuslavoristiche – di attività commerciali a supporto dell’attività istituzionale è infatti funzionale, e necessario, alla copertura dei costi dell’attività sportiva di base che, soprattutto nell’organizzazione di attività agonistiche, rappresenta un costo notevole, la cui copertura è storicamente fondata su tre “pilastri”: le quote associative e i corrispettivi specifici (quote di frequenza); le sponsorizzazioni; lo svolgimento di attività commerciali a supporto dell’attività sportiva (la gestione del bar e dell’impianto sportivo).
Se il terzo pilastro risulterà depotenziato dall’intervento governativo, considerata la sempre maggiore difficoltà nel reperimento degli sponsor, sarà inevitabile che l’onere della copertura dei costi dell’attività sportiva ricada sui fruitori della stessa, e in particolare sulle famiglie dei ragazzi, il che è tutto fuorché auspicabile.
Una ulteriore variazione è rappresentata dall’inserimento, relativamente all’attività didattica, della specifica circa il riferimento di questa all’avvio, all’aggiornamento e al perfezionamento nelle attività sportive. Si è sostanzialmente recuperata la prima formulazione dell’art. 90, c. 18, L. 289/2002, poi cancellata a seguito di successivi interventi. La precisazione appare interessante: chiarisce infatti che devono essere compresi nell’attività didattica non solo l’avvio all’attività sportiva (tipicamente riservato ai giovani e alle “scuole sportive” ma anche l’aggiornamento e il perfezionamento, cioè attività dedicate (anche) a soggetti in età adulta e (anche) a livello individuale.
iv. Viene riformulato, e meglio definito, il concetto di assenza di scopo di lucro, prevedendo, per gli enti sportivi aventi natura societaria, la possibilità di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata
- Quanto all’assenza del fine di lucro, per la quantificazione del principio di “lucro indiretto” viene operato un esplicito richiamo l’art.3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Imprese Sociali), il che comporta, rispetto all’attuale situazione, l’individuazione di indici a livello puntuale, ancorché di non semplicissima interpretazione;
- Viene ampliata (anche in questo caso, sulla scorta della disciplina delle imprese sociali) la platea dei soggetti “sotto osservazione”, aggiungendo all’originaria (dell’art. 90) previsione dei “soci ed associati”, anche le figure lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto”, con una previsione opportuna, figlia, evidentemente, dell’esperienza maturata dagli organismi di controllo nel corso delle verifiche effettuate negli anni.
v. Viene prevista – di nuovo in analogia con il sistema delle imprese sociali – la possibilità, da parte degli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di:
- Destinare una quota degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale (inferiore al 50% degli utili di esercizio e nei limiti dell’indice ISTAT di inflazione annua);
- Distribuire utili ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- Rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato secondo gli indici di cui sopra.
Si tratta di previsioni che dovrebbero incentivare l’investimento imprenditoriale nello sport; operazione già tentata ai tempi della (poi abortita) società sportiva lucrativa, anche se il vincolo del legame agli indici ISTAT e/o al tasso di interesse dei buoni postali, considerati i valori di tali indicatori negli ultimi anni, non sembra poter far risultare particolarmente attraente l’opportunità a un investitore e/o un imprenditore.
ATTENZIONE:
tale possibilità, in ogni caso, va coordinata con l’indicazione delle clausole statutarie necessarie alla fruizione della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici previste dall’art. 148, c. 8, T.U.I.R. e dall’art. 4, c. 4, d.p.r. 633/1972 i quali, come noto, richiedono l’indicazione statutarie dell’incedibilità e non rivalutabilitò della quota associativa, del divieto assoluto di distribuzione di utili e della devoluzione dell’intero patrimonio (comprese le quote associative/sociali versate) in caso di scioglimento della società.
Qualora non venga prevista esplicitamente – nella fase di correzione/integrazione della bozza – una deroga all’art. 148 T.U.I.R., la società sportiva che volesse prevedere le suddette clausole statutarie, dovrà rinunciare alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici.
vi. Viene ampliato il regime dell’incompatibilità degli amministratori a ricoprire cariche societarie nell’ambito della medesima FSN, prevedendo che tale incompatibilità non è più legata “alla medesima carica”, come previsto dall’art. 90, ma si estende a “qualsiasi carica” in altre a.s.d. o s.s.d.
La disciplina tributaria degli enti sportivi dilettantistici
Si tratta del capitolo scritto in maniera più frettolosa e meno strutturata dell’intero provvedimento.
Vengono infatti confermate esplicitamente alcune agevolazioni quali:
La non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi elargiti in favore di a.s.d. e s.s.d. dal CONI, FSN ed EPS;
L’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa agli atti costitutivi e di trasformazione delle a.s.d. e s.s.d. e FSN/EPS;
La qualifica di spesa di pubblicità dei corrispettivi erogati in favore di a.s.d. e s.s.d.– fino all’importo di € 200.000,00 – a fronte di specifica attività del beneficiario;
L’art. 149 del T.U.I.R. (che prevede l’inapplicabilità della perdita di Ente non Commerciale in capo alle a.s.d.);
L’art. 148, comma 3, del T.U.I.R. (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici)
La Legge 398/1991, ivi compresa la previsione dell’esenzione ai fini IVA e la non concorrenza alla determinazione del reddito dei premi di addestramento e formazione;
L’art. 25, della L. 133/1999 (non concorrenza alla formazione del reddito dei due eventi commerciali annui per i soggetti che hanno optato per la L. 398/1991 nel limite di € 51.645,69 e disciplina dei compensi, rimborsi e premi erogati agli sportivi dilettanti – quest’ultima con le limitazioni che saranno evidenziate infra);
Molto importante risulta invece la precisazione ai sensi della quale “Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica l’art. 4. comma 4. del d.p.r. n. 633 del 1972” che, se confermata nel testo definitivo, dovrebbe risolvere il problema del (non) assoggettamento ad imposta dei corrispettivi specifici da parte delle S.S.D. (ovviamente in presenza di tutti i “requisiti qualificanti”
È infine previsto che “per tutto quanto non regolato dal presente decreto legislativo, è fatta salva l’applicazione del Testo Unico delle imposte sui Redditi”
Ci si chiede, a questo punto, quale possa essere il destino delle disposizioni non esplicitamente citate (ad esempio, le disposizioni in materia di IVA), ma appare evidente che tali norme continuino ad essere applicabili, laddove non compaiano tra quelle espressamente abrogate.
I rapporti di lavoro sportivo
Si tratta, probabilmente, del capitolo più importante e di maggiore impatto per i sodalizi sportivi di tutta la riforma.
L’importanza, e l’urgenza, di una rivisitazione della materia era già stata evidenziata in sede di legge delega, rivisitazione la cui necessità è assurta a necessità indifferibile nel periodo di lockdown a seguito della pandemia Covid-19, quando è emersa in tutta la sua gravità la situazione dei collaboratori sportivi, privi di tutele previdenziali e ammortizzatori sociali, che sono stati oggetto del provvedimento di sostegno previsto dall’art. 95 del decreto “cura Italia” (i 600 euro erogati dalla società Sport e Salute).
La bozza di testo unico contiene un intero titolo dedicato alla riforma del lavoro sportivo, improntata, secondo i principi della legge delega, al superamento della tradizionale distinzione tra professionismo e dilettantismo nonché alla tutela del lavoratore, in termini di accesso e trattamento economico e normativo e all’individuazione di una disciplina assicurativa, fiscale e previdenziale idonea a garantire la stabilità e la sostenibilità del sistema sport.
Il risultato già evidente a una prima lettura è quello di una ridefinizione dell’area lavorativa attraverso un’ampia disciplina del rapporto che vuole essere completa sotto il profilo sostanziale e del trattamento fiscale e contributivo, a fronte di una correlata compressione del regime dei redditi diversi di cui all’art. 67 co.1 lett. m) T.U.I.R., circoscritto alle sole prestazioni a carattere amatoriale.
La finalità evidente è quella di eliminare zone grigie tra lavoratori e volontari definendo quando la prestazione sia svolta per passione e quando per lavoro, in analogia con il sistema adottato dalla riforma del Terzo Settore alla quale si attinge per la figura del volontario sportivo e per il connesso regime di incompatibilità con la prestazione lavorativa.
Tuttavia l’impressione è che, pur nell’attuazione dei principi contenuti nella delega, da un lato siano privilegiate le (doverose) esigenze di tutela dei lavoratori rispetto alla stabilità e sostenibilità del sistema sport, gravato da nuovi oneri previdenziali e assicurativi, e, dall’altro, che le scelte e le tecniche legislative operate nel disciplinare i rapporti e nel delineare il confine tra attività amatoriale e lavorativa non consentano di superare quelle incertezze interpretative che da anni pesano sui sodalizi sportivi dilettantistici nella gestione dei rapporti con le risorse umane.
Analizziamo dunque per sommi capi le novità contenute nella bozza di riforma.
Prestazioni lavorative
Sono lavoratori sportivi – secondo la definizione elaborata nel testo – gli atleti, allenatori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso, fatte salve le prestazioni amatoriali.
Un primo dubbio affiora immediatamente: e gli istruttori? Sono compresi tra gli allenatori e direttori tecnici o sono volutamente esclusi dalla riforma? È opportuno che gli interventi correttivi della bozza risolvano immediatamente tale incertezza, atteso che si tratta della categoria forse più interessata dalla riforma.
Ciò premesso, l’attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, potrà costituire oggetto di:
- rapporto di lavoro subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo – anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409 n.3 c.p.c.;
- prestazione occasionale secondo la disciplina della c.d. PrestO di cui all’art. 54 bis del D.L. n. 50/17 convertito in L. 96/17.
Quindi nell’attuazione della delega viene individuata la figura del lavoratore sportivo (peraltro con un’elencazione che lascia dubbi in ordine a tutte quelle qualifiche di ausiliari e assistenti all’attività sportiva che potrebbero non trovare più collocazione nel quadro rinnovato dell’art. 67), ma difetta una specifica qualificazione giuridica del rapporto che, in tal senso, non viene ricondotto a un contratto tipo – subordinato, autonomo o di terzo genere – caratterizzato da una propria disciplina legale da applicare, quantomeno in via presuntiva, alla prestazione di lavoro sportivo.
Tale soluzione è adottata nel testo della nuova riforma – così come in precedenza nella L. 91/81 – soltanto per il lavoro sportivo professionistico che se svolto in via principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Per il resto, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione e delle circostanze del caso concreto, il rapporto potrà ricondursi tanto all’area subordinata quanto all’area autonoma, individuate secondo i criteri e i parametri di diritto comune.
Lavoro subordinato
La forma subordinata del lavoro sportivo prevede comunque una disciplina speciale, che ricalca la fattispecie già delineata dalla L. 91/81 per gli sportivi professionisti. In particolare, considerata la natura della prestazione e il contesto in cui si svolge, non trovano applicazione le disposizioni sostanziali e procedurali relative alla disciplina del licenziamento individuale per giusto motivo o per giusta causa, né le connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno) nonché alcune norme dello Statuto dei lavoratori che risultano incompatibili con l’ordinamento sportivo (regime autorizzatorio per gli impianti audiovisivi, divieto di accertamenti sanitari, tutela delle mansioni, procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle FSN,DSA o dagli EPS). È previsto il contratto a termine fino a cinque anni; consentito l’inserimento di clausole compromissorie; vietate le clausole di non concorrenza.
Tale applicazione generalizzata è sicuramente un passaggio epocale per la posizione degli atleti c.d. professionisti di fatto che svolgono in via principale attività di vertice, adeguatamente retribuita, ma che operando in settori non qualificati come professionistici dalla federazione di appartenenza sono trattati a tutti gli effetti come dilettanti: a essi non è oggi possibile applicare in via analogica o estensiva la disciplina del contratto prevista dalla L. 91/81 per i professionisti, in quanto norma speciale; e quindi i relativi rapporti, sussistendone i presupposti, devono essere inquadrati o riqualificati secondo le regole di diritto comune.
Il lavoro autonomo, nella forma coordinata e continuativa
Il testo di riforma non esclude teoricamente la possibilità di ricorrere al contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma di fatto, alla luce del quadro vigente di riferimento e delle modifiche che la riforma intende apportare – con l’abrogazione dell’art. 2 co. 2, lett.d) del D.lg.vo 81/2015 – tale configurabilità appare alquanto ridimensionata, quanto meno come previsione ex lege e salva la possibilità di ricorrere alla contrattazione collettiva e alla certificazione dei contratti.
Il testo infatti si riferisce alle collaborazioni previste dall’art. 409 n. 3 c.p.c., norma che estende la tutela processuale del lavoro a rapporti non riconducibili alla subordinazione ma attratti al rito speciale stante la soggezione socio-economica del collaboratore rispetto al committente e caratterizzati da continuità, coordinazione e prevalente personalità della prestazione resa.
Secondo tale definizione – integrata dal Jobs Act autonomi (art. 15, 1° co., lett. a), L. 22.5.2017, n. 81) – la collaborazione genuinamente autonoma presuppone l’autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti.
Quando invece la coordinazione e l’organizzazione siano unilateralmente determinate dal committente, scatta la presunzione di cui all’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, sempre fatta salva nell’articolato della bozza e che, in attuazione del principio di centralità del contratto subordinato come forma comune del rapporto di lavoro, prevede l’applicazione ex lege della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, salve alcune ipotesi di deroga espressamente previste; tra queste la disposizione al comma 2 lett. d), sulle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, che nell’articolato del T.U. viene cancellata.
Con la riforma in atto – abrogata la possibilità di stipulare valide co.co.org. in deroga e considerata per effetto della novella introdotta dalla L. 128/19 di conversione del D.L. 191/19 la recente estensione delle stesse alle prestazioni anche solo prevalentemente personali e caratterizzate da qualsiasi modalità organizzativa anche diversa dai tempi e luoghi del lavoro, quali parametri dell’etero organizzazione – di fatto si restringe l’area delle collaborazioni coordinate e continuative alle sole prestazioni autonome.
Il timore è che nella pratica – al di fuori delle prestazioni rese in un contesto di effettiva pluricommittenza – simili caratteristiche siano raramente riscontrabili, atteso che le prestazioni si svolgono necessariamente presso l’impianto sportivo secondo modalità di coordinamento che difficilmente possono essere concordate tra le parti e il più delle volte sono invece etero-determinate dal sodalizio sportivo.1
Lo spazio per le collaborazioni organizzate dal committente rimane quindi legato alla sola contrattazione collettiva, ai sensi dell’art.2 co. 2 lett.a) che consente appunto la possibilità di stipulare valide co.co.org. in deroga alla riconversione ex lege della disciplina del rapporto.
Si tratterà di capire e di verificare quali possano essere le associazioni comparativamente più rappresentative e se assumeranno un ruolo significativo diretto a facilitare il ricorso a contratti di collaborazione potenzialmente genuini perché riferiti a situazioni di fatto coerenti con lo schema adottato, garantendo nel contempo adeguate tutele economiche e normative ai prestatori; incombe tuttavia anche il rischio opposto – in assenza di adeguata rappresentatività delle associazioni stipulanti – di pratiche di dumping contrattuale che porterebbero, sul piano delle tutele economiche e normative dei lavoratori sportivi, a vanificare i principi perseguiti dalla riforma.
In tale nuovo assetto potrebbe essere rivitalizzato l’istituto della certificazione dei contratti previsto dagli artt. 75 e segg. del D.Lg.vo 276/2003, anche alla luce di alcuni passaggi contenuti nella bozza di testo unico che riconoscono agli accordi collettivi stipulati da FSN e DSA con i rappresentanti delle categorie dei lavoratori la possibilità di individuare buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione; tuttavia considerati gli effetti della certificazione e la difficoltà di determinare in concreto i parametri di una collaborazione coordinata e continuativa, e salvi i correttivi che potrebbero essere introdotti con decreti attuativi, rimangono allo stato diverse perplessità su un effettivo e utile ricorso alle procedure di certificazione.
La prestazione occasionale
Il riferimento è all’art. 54bis DL 50/17 convertito in L.96/17, ovvero al c.d. PrestO, che ha sostituito il sistema previgente dei voucher.
Rispetto alle regole ordinarie – che, ricordiamo per sommi capi, consentono l’impiego di lavoratori occasionali per utilizzatori con meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, per l’importo massimo di euro 5.000 per ogni prestatore ma di euro 2.500 se percepiti da un medesimo utilizzatore – sono previste alcune deroghe interessanti:
- non si applicano i limiti dimensionali per cui risulterebbe possibile utilizzare le prestazioni occasionali anche con un numero superiore a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- si estendono le deroghe già previste per gli steward delle società professionistiche e quindi vale il maggior limite di euro 5.000 per ciascun prestatore anche se erogato dal medesimo utilizzatore a.s.d./s.s.d.;
- non si applica il limite delle quattro ore consecutive giornaliere.
Si ricorda che il trattamento previdenziale delle PrestO pone interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Si ricorda altresì che le prestazioni occasionali sono vietate dal comma 14 lett. d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi: potrebbe forse essere di interesse una deroga anche su questo punto, allo scopo di favorire la progettualità con le amministrazioni pubbliche?
La prestazione amatoriale
Le a.s.d./s.s.d. nello svolgimento delle proprie attività istituzionali possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali.
La definizione ricalca in sostanza quella contenuta nel Codice del Terzo Settore (art.17 D. Lgs. 117/17) introducendo le finalità amatoriali sportive quale omologo delle finalità solidaristiche proprie del terzo settore. Vengono inoltre mutuati: l’espressa incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro con l’ente tramite il quale il volontario svolge l’attività amatoriale, l’obbligo di assicurazione e la figura del volontario occasionale.
Diverso invece il requisito della gratuità: mentre nel Codice del Terzo Settore è ribadito ed esteso in via generale a tutti gli ETS il divieto di remunerare l’attività del volontario salvo il rimborso delle spese documentate e con espresso divieto di far ricorso a rimborsi spese forfetari, nell’ambito sportivo dilettantistico è ammessa la possibilità di riconoscere premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari ai quali si applica il regime di cui all’art.67 co.1 lett. m) T.U.I.R.
Tale disposizione rimane formalmente inalterata rispetto al testo vigente che oggi conosciamo ma sostanzialmente ridimensionata per effetto di due interventi di interpretazione autentica:
a. la qualificazione di redditi diversi si intende operante solo nei limiti della soglia di imponibilità fiscale di euro 10.000;
b. per “premi” e “compensi” erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
Dunque il collaboratore sportivo amatoriale – che rende le prestazioni in qualità di volontario e quindi al di fuori di un rapporto obbligatorio di scambio tra prestazione e remunerazione – potrà percepire nei limiti di euro 10.000 annui, soltanto:
- indennità di trasferta e rimborsi spese forfetari, quindi emolumenti correlati a una specifica attività che richieda un ristoro delle spese sostenute o comunque un indennizzo non avente alcuna natura (e consistenza) corrispettiva;
- oppure premi e compensi occasionali, non correlati all’attività svolta in termini di tempo e di prestazioni, ma riconosciuti per il risultato ottenuto nelle competizioni sportive.
L’ambito della prestazione amatoriale si presta a molteplici interrogativi e ripropone tante delle incertezze interpretative che da anni interessano l’applicazione della norma agevolativa.
In prima battuta possiamo porci una prima serie di domande.
1. Innanzitutto: quando l’erogazione di premi e compensi si considera occasionale?
2. Si tratterà poi di capire se e quando i rimborsi spese e le indennità di trasferta – che sono erogabili anche per prestazioni amatoriali dirette alla formazione e alla didattica e quindi verosimilmente continuative e abituali – possano diventare indici di prestazione lavorativa: è ipotizzabile una presunzione di amatorialità?
3. E poi: come qualificare il rapporto nel caso di superamento del limite di euro 10.000? E quali conseguenze sul trattamento fiscale e previdenziale delle somme eccedenti?
4. E ancora: il testo prevede la figura dell’associato o tesserato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali dell’ente dilettantistico nello svolgimento delle loro funzioni, al quale non si applicherebbero le disposizioni dettate per le prestazioni amatoriali ma la portata di tale disposizione non è così immediata, presta il fianco alla difficoltà di individuare l’occasionalità delle prestazioni ed è frutto probabilmente del recepimento della figura del volontario occasionale contenuta nel CTS, che in tale ambito si giustifica per il fatto di non dover essere iscritta al registro dei volontari ivi previsti, ma che in questa trasposizione necessita di chiarimenti.
Altri dubbi interessano poi le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale: da un lato, coerentemente con l’impianto adottato dal T.U. si evita una tipizzazione e si precisa che, ricorrendone i presupposti, potranno essere oggetto di collaborazioni autonome ai sensi dell’art.409 co.1 n. 3 c.p.c. (esclusa quindi ogni etero-organizzazione del committente); dall’altro rimangono definite nel testo dell’art. 67, con i correttivi apportati. Quindi saranno inquadrate nei redditi diversi fino al limite di euro 10.000 annui ma a rigore, considerato il nuovo significato attribuito ai compensi, dovrebbero essere remunerate soltanto con rimborsi forfetari di spesa e indennità di trasferta. La delega chiedeva una disciplina che tenesse conto delle peculiarità di tali collaborazioni e del loro fine non lucrativo ma in questa prima stesura non sembra chiarita la loro collocazione: volontaristica/amatoriale o lavorativa?
L’impressione è quindi che il “nuovo” art. 67 così ridimensionato, non sia idoneo a prevenire e contenere il diffondersi del contenzioso che da anni ha investito l’applicazione della norma agevolativa:
da un lato i principi della riforma superano e disconoscono quell’orientamento evolutivo formatosi nella giurisprudenza di merito che ha individuato nella prestazione dilettantistica un’area lavorativa di terzo genere e coerentemente rafforzano l’incipit della norma, che esclude dal regime dei redditi diversi le prestazioni lavorative subordinate o autonome professionali;
dall’altro, le soluzioni adottate non sembrano offrire strumenti idonei a prevenire e a contenere il diffondersi di nuove ondate di contenzioso sul concetto di amatorialità o sulla natura volontaristica della prestazione anche in ossequio al principio consolidato di presunzione di onerosità del rapporto di lavoro.
Per altro verso invece l’impianto che ne esce, nella delimitazione senz’altro perfettibile tra area lavorativa e volontariato, avvicina e rende compatibile, sotto questo profilo, il settore sportivo dilettantistico alla disciplina del Terzo Settore.
Non solo per l’estensione delle tutele economiche e normative ai prestatori di lavoro ma anche – potrebbe non essere un’ipotesi azzardata – in vista di un raccordo tra la figura speciale del volontario sportivo che, seppure caratterizzata dall’assenza del requisito di gratuità, potrebbe equipararsi al volontario degli ETS nella qualificazione delle ODV e soprattutto delle APS sia in termini di prevalenza dell’attività di volontariato sia ai fini del rispetto del rapporto numerico tra volontari e lavoratori che caratterizzano tali tipologie di ETS.
Il trattamento previdenziale e assistenziale del lavoratore sportivo
I principi evidenziati dalla bozza di riforma sono i seguenti:
- Per tutto quanto non regolato dal presente decreto legislativo, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva;
- In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro;
si tratta di previsione che avranno un notevole impatto sull’organizzazione e sui costi dei sodalizi sportivi, tanto che, nelle disposizioni finali, è espressamente previsto che tali norme entreranno in vigore il 01/01/2022, proprio al fine di consentire ai sodalizi sportivi di operare la necessaria programmazione.
In particolare quanto al trattamento assicurativo, viene previsto l’obbligo generalizzato di assicurazione INAIL
i. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, …, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche;
ii. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativasi applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL …;
iii. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all’ articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, come successivamente modificato e integrato, e nei relativi provvedimenti attuativi. La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all’ INAIL
Il trattamento previdenziale appare più complesso:
a. I lavoratori subordinati sportivi dovranno essere iscritti al fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’INPS – ex ENPALS, il quale assumerà la denominazione di “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi;
b. I lavoratori sportivi titolari di contratto di co.co.co o che svolgono prestazioni autonome occasionali dovranno essere iscritti in un’apposita sezione del “Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi”, a cui si applicherà la disciplina previdenziale prevista per i lavoratori iscritti nella c.d. “gestione separata” INPS ex L. 335/1995;
c. I lavoratori sportivi autonomi saranno assoggettati a un versamento sulla base di un compenso mensile determinato convenzionalmente con decreto del Ministero del Lavoro. I contributi saranno interamente a carico del lavoratore sportivo autonomo.
Ai sensi dell’art. 5, c.1, della Legge delega, e al fine di garantire la sostenibilità del sistema sportivo, dilettantistico è previsto – per i soli lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co – che l’aliquota contributiva sarà pari al 10%
La specifica previsione dell’applicabilità di tale aliquota ai soli titolari di rapporti di co.co.co. (ferme restando le perplessità sopra evidenziate circa l’applicabilità di tale regime ai lavoratori sportivi) lascia aperto il dubbio circa il trattamento e l’aliquota da applicare ai lavoratori sportivi titolari di P.IVA:
– tali lavoratori dovranno essere iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi o alla “gestione separata INPS”?
– agli stessi sarà applicata l’aliquota speciale 10%, l’aliquota prevista per la Gestione Separata (25,72%) o l’aliquota ordinaria della gestione “ex ENPALS” (33%)?
d. I lavoratori sportivi titolari di contratto di co.co.co “amministrativo gestionale” dovranno essere iscritti nella c.d. “gestione separata” INPS ex L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale (aliquota ordinaria 25,72%).
per tali rapporti la qualificazione come redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta come operante soltanto entro il limite reddituale per l’esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
In sostanza (pare, salvo eventuali diverse indicazioni) per tali lavoratori, fino alla soglia di compenso di 10.000 € annui “non cambia nulla” rispetto alla situazione attuale (fermo restando l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego e di assicurazione INAIL).
Il trattamento tributario del lavoratore sportivo
Il principio base della tassazione dei redditi derivanti da lavoro sportivo è che
La soglia di esenzione fiscale di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo di cui all’art. 1, quale che sia la tipologia di rapporto
In sostanza, su tutti i redditi derivanti da lavoro sportivo (tutti, anche quelli relativi a un rapporto di lavoro subordinato) è prevista una soglia di esenzione fiscale in relazione alla “fascia esente” di € 10.000, a oggi prevista quale fascia di esenzione per i soli “compensi sportivi”
Non solo:
Nei settori dilettantistici, sul reddito imponibile da lavoro sportivo di cui all’art. 1, quale che sia la tipologia di rapporto, sino allo scaglione di euro 65.000,00, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento
Dunque, superata la soglia esente di 10.000,00 €, ed entro la soglia di 65.000,00 € (corrispondente alla soglia attualmente prevista per i lavoratori autonomi “forfettari” in possesso di P.IVA) l’aliquota di imposta sarà del 15% (contro l’attuale 23% + add.li fino alla soglia di € 30.658,28).
Infine, è prevista la deducibilità integrale ai fini delle imposte sui redditi dei contributi previdenziali e assistenziali versati dalle federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società o associazioni sportive o dai lavoratori sportivi in ottemperanza a disposizioni di legge, i quali non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
Lo “scambio” è evidente: a fronte di una (sensibile) ulteriore riduzione del carico tributario (che, attenzione, opererà su TUTTI i redditi da lavoro sportivo) viene richiesto ai sodalizi sportivi e ai lavoratori sportivi un “sacrificio” a livello previdenziale, assistenziale e di inquadramento dei lavoratori.
Le semplificazioni e il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Infine, un capitolo importante è dedicato alle semplificazioni e alla disciplina della certificazione dell’attività sportiva svolta dalle a.s.d. e s.s.d.
Iniziando dalle semplificazioni, vengono previsti:
i. La soppressione del Modello EAS;
ii. Il riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina della certificazione dell’attività sportiva svolta dalle a.s.d. e s.s.d., anche attraverso la predisposizione di moduli di autocertificazione (tale passaggio non è tuttavia analiticamente disciplinato ed è indicato come “da rivedere”);
iii. La possibilità, per le a.s.d., in deroga al d.p.r. 361/2000, di acquisire la personalità giuridica (previa costituzione per atto notarile) mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive (non viene tuttavia indicata la soglia patrimoniale minima per la richiesta);
iv. L’esenzione dall’obbligo di emissione della fatturazione elettronica per le a.s.d./s.s.d. iscritte al Registro CONI che abbiano optato per la L. 398/1991 e non abbiano superato la soglia di proventi commerciali di € 65.000;
v. L’esenzione per le a.s.d./s.s.d. iscritte al Reg. CONI dall’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi qualora non superino, congiuntamente, i limiti di € 30.000 di corrispettivi e di € 65.000 di proventi commerciali;
Per quanto concerne il “Registro CONI” le novità sono le seguenti:
- Innanzitutto, il “Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche” sarà sostituito dal nuovo “Registro delle attività sportive Dilettantistiche”, che sarà sempre gestito dal CONI, e nel quale trasmigreranno automaticamente i sodalizi già iscritti nel vecchio registro;
- Anche il nuovo Registro certificherà il riconoscimento ai fini sportivi degli enti regolarmente iscritti;
- Nel nuovo “Registro”, che avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del “RUNTS” in relazione al Terzo Settore, dovranno essere iscritti:
Tutti i dati anagrafici del sodalizio, del legale rappresentante, dei membri del consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo;
i dati anagrafici di tutti i tesserati, compresi quelli minori;
le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole società ed associazioni sportive affiliate;
l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;
il rendiconto economico e finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea, e il relativo verbale;
i verbali che comportano modifiche statutarie (con i relativi statuti modificati), gli organi statutari e la sede legale;
Tutti i suddetti dati e notizie dovranno essere comunicati al CONI per il tramite degli Organismi di Affiliazione (FSN o EPS).
Tali dati e notizie, una volta iscritti al Registro, saranno opponibili ai terzi (compresi eventuali Organi di Controllo tributario o giuslavoristico)
Il CONI dovrà definire, con proprio regolamento (che, a questo punto, dovrebbe abrogare il regolamento vigente) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la disciplina e il funzionamento del nuovo Registro.
12. Conclusioni
Come appare evidente, si tratta di una riforma poderosa, non priva di lacune tecniche (probabilmente derivanti anche da un difetto di coordinamento tra gli estensori delle varie parti) e sicuramente perfettibile nel percorso che precederà la promulgazione, ma che contiene importanti e pregevoli interventi strutturali.
Se possiamo permetterci di operare una critica all’architettura del provvedimento, è che lo stesso, similmente al Codice del Terzo Settore, appare più congeniale – per quanto riguarda la disciplina dei sodalizi sportivi – agli enti di media e grande dimensione, laddove gli adempimenti richiesti, sia in relazione alla disciplina del lavoro sportivo che alla procedura del nuovo Registro, potrebbero risultare eccessivamente pesanti, in termini burocratici, per i piccoli enti, che rappresentano tuttavia la grande maggioranza dei sodalizi sportivi italiani.
Servirebbe, forse, un po’ di “sburocratizzazione” per le piccole e piccolissime società sportive, individuando soglie di esenzione in relazione ad alcuni adempimenti entro determinate soglie di entrate complessive (ad es. 30 o 50 mila euro).
- Si tratta dunque di una scelta diametralmente opposta rispetto al tentativo di riforma operato con la legge di Bilancio 2018 dove la collaborazione resa per fini istituzionali di cui all’art. 2 co.2 lett.d) veniva individuata come tipo legale della prestazione di lavoro sportivo dilettantistico. [↩]