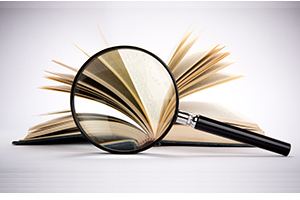Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”
Il legislatore ha introdotto, tra il 2019 e il 2022, un nuovo obbligo per tutti gli operatori economici: l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il presente intervento ha l’obiettivo di svolgere una disamina circa il presupposto soggettivo, ovvero perimetrare gli enti che devono sottostare al nuovo adempimento; seguiranno interventi specifici per chiarire in cosa consistano, rispettivamente, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e quali azioni debbano adottare gli amministratori per dotarsi di un assetto “adeguato”
Questo contenuto è disponibile solo in abbonamento. Effettua il login oppure prova l'abbonamento gratuito per 30 giorni